| |

 |
| |
|

Luras

L'autore

Le
opere

La
collezione

La
tecnica

Il
sughero

L'edicola

I
commenti



|
Le origini
 Luras,
paese della Gallura di circa 2.800 abitanti, situato nella regione nord
orientale dell'Isola di Sardegna, si estende su un poggio granitico
dell'altipiano del Limbara, a 508 metri di altitudine. Luras,
paese della Gallura di circa 2.800 abitanti, situato nella regione nord
orientale dell'Isola di Sardegna, si estende su un poggio granitico
dell'altipiano del Limbara, a 508 metri di altitudine.
Un tempo veniva
chiamata Villa Lauras o Oppidum Luris, e l'origine
stessa del nome viene spesso attribuita a lura (otre) oppure
a laurus (alloro). Tra le ipotesi avanzate sull'origine del
paese ve ne sono alcune che, secondo quanto affermato da diversi storici,
lo vorrebbero come "una delle cinque colonie" che gli Etruschi
fondarono nell'Isola dopo l'862 a.C. Oppure fondato da una parte dei
4.000 coloni ebrei deportati in Sardegna dall'imperatore romano Tiberio
nel 19 d.C. A rafforzare ancora quest'ipotesi vi sono diversi particolari
riferibili agli usi e costumi luresi, all'intraprendenza commerciale,
ad alcune pietanze e a elementi caratteriali degli stessi abitanti.
|
| |
La
storia
 Il
primo documento storico che cita luras è la Carta Pisana del 1300,
dove vi sono elencate tutte le ville del Giudicato suddivise
in Curatorie. Luras faceva parte della Curatoria di Gemini
Josso. Nel periodo giudicale e spagnolo-aragonese nella zona di Luras
sorgevano dei villaggi che sono stati abbandonati in epoche diverse a
causa delle pestilenze, delle carestie e delle incursioni dei barbari.
Siffilionis (oggi Silonis) sorgeva presso l'antica chiesa
di San Pietro, che era la parrocchiale di questo villaggio; Canahim
(o Canahini), Il
primo documento storico che cita luras è la Carta Pisana del 1300,
dove vi sono elencate tutte le ville del Giudicato suddivise
in Curatorie. Luras faceva parte della Curatoria di Gemini
Josso. Nel periodo giudicale e spagnolo-aragonese nella zona di Luras
sorgevano dei villaggi che sono stati abbandonati in epoche diverse a
causa delle pestilenze, delle carestie e delle incursioni dei barbari.
Siffilionis (oggi Silonis) sorgeva presso l'antica chiesa
di San Pietro, che era la parrocchiale di questo villaggio; Canahim
(o Canahini),  identificabile
con l'attuale Canaili, si estendeva intorno alla chiesa di San
Michele e il villaggio di Canarhan, nella regione che oggi
viene chiamata Carana, e aveva come parrocchiale la chiesa di
San Nicola e San Bartolomeo. Sempre nella curatoria
di Canahini sorgevano i villaggi di Astaina e di Hagiana,
mentre nella curatoria di Gemini vi era un altro villaggio
denominato Campo de Vigne o de Vinyes. Luras fece parte
quindi del Marchesato di Gallura e vi rimase fino al 1839. Ed
è proprio nell'800 che Luras raggiunge un certo benessere, ossia
quando alle tradizionali e tutt'oggi presenti attività agricole
si aggiunsero quelle commerciali che videro i luresi impegnati a vendere
in tutta l'Isola, e non solo, i propri manufatti: berrittas (antichi
copricapi del costume maschile), lana, pelli, lavorati del sughero e del
ferro, stoffe, vini, acquavite, formaggi, granaglie, ecc. Oggi l'economia
dei luresi è basata sull'agricoltura, sull'allevamento, sulla lavorazione
del sughero e del granito e sulla viticoltura. Nel territorio di Luras
si trovano le vigne più estese e forse meglio coltivate dell'alta
Gallura, dalle quali si producono vini apprezzati oltre gli stessi confini
sardi e nazionali: il vermentino, il moscato e il famosissimo
Nebiolo di Luras. identificabile
con l'attuale Canaili, si estendeva intorno alla chiesa di San
Michele e il villaggio di Canarhan, nella regione che oggi
viene chiamata Carana, e aveva come parrocchiale la chiesa di
San Nicola e San Bartolomeo. Sempre nella curatoria
di Canahini sorgevano i villaggi di Astaina e di Hagiana,
mentre nella curatoria di Gemini vi era un altro villaggio
denominato Campo de Vigne o de Vinyes. Luras fece parte
quindi del Marchesato di Gallura e vi rimase fino al 1839. Ed
è proprio nell'800 che Luras raggiunge un certo benessere, ossia
quando alle tradizionali e tutt'oggi presenti attività agricole
si aggiunsero quelle commerciali che videro i luresi impegnati a vendere
in tutta l'Isola, e non solo, i propri manufatti: berrittas (antichi
copricapi del costume maschile), lana, pelli, lavorati del sughero e del
ferro, stoffe, vini, acquavite, formaggi, granaglie, ecc. Oggi l'economia
dei luresi è basata sull'agricoltura, sull'allevamento, sulla lavorazione
del sughero e del granito e sulla viticoltura. Nel territorio di Luras
si trovano le vigne più estese e forse meglio coltivate dell'alta
Gallura, dalle quali si producono vini apprezzati oltre gli stessi confini
sardi e nazionali: il vermentino, il moscato e il famosissimo
Nebiolo di Luras.
|
| |
Il dialetto
 Per
cercare una spiegazione al perché Luras, a differenza degli altri
centri della Gallura, abbia mantenuto l'originaria parlata sarda bisogna
ricondursi alle diverse ipotesi che tentano di dare una spiegazione possibile
e veritiera sulle motivazioni. Per
cercare una spiegazione al perché Luras, a differenza degli altri
centri della Gallura, abbia mantenuto l'originaria parlata sarda bisogna
ricondursi alle diverse ipotesi che tentano di dare una spiegazione possibile
e veritiera sulle motivazioni.
Intorno al 1200 la Gallura fu infestata da una grave epidemia. Solo Luras
rimase immune e potè quindi difendersi dai Còrsi che intanto
avevano occupato la parte superiore dell'Isola conquistando i luoghi lasciati
deserti; questa tesi giustificherebbe la difesa della lingua sarda sul
dialetto gallurese, che ha chiare origini còrse.
Il mantenimento della parlata sarda potrebbe essere nato anche dall'esigenza
di dover comunicare con le popolazioni dell'interno della Sardegna dovuto
al dinamismo commerciale dei luresi.
L'originalità dei lurisincos, come etnicamente vengono
chiamati, esce allo scoperto proprio nel dialetto il quale, oltre alla
musicalità dell'accento, si distingue dalle altre varianti logudoresi
della sardegna del centro - nord per altre sfumature.
|
| |
L'archeologia
 Sepulturas
de zigantes o de paladinos, così i luresi solevano chiamare
i Dolmen, importantissimi monumenti del megalitismo funerario
del periodo neolitico, che costituiscono un esempio significativo di una
delle maggiori concentrazioni di tali sepolture in Sardegna. Nel territorio
di Luras, infatti, ve ne sono ben quattro: l'Allée couverte
di Ladas e i dolmen a struttura semplice di Alzoledda, di
Ciuledda e di Billella. Molto ben conservati nelle loro
strutture realizzate in granito locale, i dolmen di Luras costituiscono,
insieme all'allée di Ladas, la cui copertura è costituita
da due lastroni piatti, uno dei quali risulta essere, per dimensioni,
il secondo in tutto il bacino del Mediterraneo, un'interessante sequenza
nell'evoluzione della tipologia costruttiva di questi monumenti megalitici
che, partendo dall'esperienza del dolmen semplice dei periodi neolitici,
porta alla realizzazione di tombe a galleria, le allée couvertes,
e quindi alle Tombe dei giganti. Sepulturas
de zigantes o de paladinos, così i luresi solevano chiamare
i Dolmen, importantissimi monumenti del megalitismo funerario
del periodo neolitico, che costituiscono un esempio significativo di una
delle maggiori concentrazioni di tali sepolture in Sardegna. Nel territorio
di Luras, infatti, ve ne sono ben quattro: l'Allée couverte
di Ladas e i dolmen a struttura semplice di Alzoledda, di
Ciuledda e di Billella. Molto ben conservati nelle loro
strutture realizzate in granito locale, i dolmen di Luras costituiscono,
insieme all'allée di Ladas, la cui copertura è costituita
da due lastroni piatti, uno dei quali risulta essere, per dimensioni,
il secondo in tutto il bacino del Mediterraneo, un'interessante sequenza
nell'evoluzione della tipologia costruttiva di questi monumenti megalitici
che, partendo dall'esperienza del dolmen semplice dei periodi neolitici,
porta alla realizzazione di tombe a galleria, le allée couvertes,
e quindi alle Tombe dei giganti.
|
| |
Gli olivastri
millenari
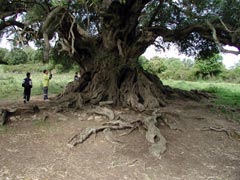 Gli
olivastri millenari di Santu Baltolu di Carana sono inseriti
in un incantevole contesto naturale, sulle sponde del Lago Liscia,
dove il contrasto tra la montagna granitica e lo stesso Lago dà
luogo a un'unità paesaggistica di assoluto valore. Il più
vecchio di questi olivastri, s'ozzastru, come viene confidenzialmente
ma rispettosamente chiamato dai luresi, presenta a metri 1,3 da terra
una circonferenza di circa 12 metri per un'altezza di 8 metri e, secondo
alcuni studi, dovrebbe avere tra i 3.000 ed i 4.000 anni di età,
il che ne fa uno degli alberi più vecchi d'Europa. Questo "patriarca
della natura", dichiarato nel 1991 Monumento naturale e
ormai inserito con grande risalto nelle più importanti guide naturalistiche,
rientra oggi nella lista dei "Venti alberi secolari", uno per
ogni Regione italiana, da tutelare e dichiarare Monumento Nazionale con
decreto ministeriale. Gli
olivastri millenari di Santu Baltolu di Carana sono inseriti
in un incantevole contesto naturale, sulle sponde del Lago Liscia,
dove il contrasto tra la montagna granitica e lo stesso Lago dà
luogo a un'unità paesaggistica di assoluto valore. Il più
vecchio di questi olivastri, s'ozzastru, come viene confidenzialmente
ma rispettosamente chiamato dai luresi, presenta a metri 1,3 da terra
una circonferenza di circa 12 metri per un'altezza di 8 metri e, secondo
alcuni studi, dovrebbe avere tra i 3.000 ed i 4.000 anni di età,
il che ne fa uno degli alberi più vecchi d'Europa. Questo "patriarca
della natura", dichiarato nel 1991 Monumento naturale e
ormai inserito con grande risalto nelle più importanti guide naturalistiche,
rientra oggi nella lista dei "Venti alberi secolari", uno per
ogni Regione italiana, da tutelare e dichiarare Monumento Nazionale con
decreto ministeriale.
|
| |
Le
chiese
 Nel
1765, per ordine del Vescovo di Civita Pietro Paolo Carta, venne distrutta
l'ormai diroccata chiesa di San Giacomo, ed in sostizuzione venne
costruita la nuova parrocchiale dedicata alla Madonna del Rosario,
Patrona di Luras, austera chiesa in stile neoromanico che, con facciata
in granito a vista e l'interno a tre navate, con le arcate ed i rossi
mattoni delle volte a botte, rappresenta un prezioso esempio di stile
di architettura religiosa in Gallura. Pregevoli le bussole in legno scolpito,
del 1907, il battistero marmoreo del XIX secolo, la Madonna con Bambino,
dipinto manierista del XVII secolo, La Pentecoste, dipinto di
Antonio Caboni (1874), Il Purgatorio, dipinto di Giovanni
Patrone del 1927. Nel
1765, per ordine del Vescovo di Civita Pietro Paolo Carta, venne distrutta
l'ormai diroccata chiesa di San Giacomo, ed in sostizuzione venne
costruita la nuova parrocchiale dedicata alla Madonna del Rosario,
Patrona di Luras, austera chiesa in stile neoromanico che, con facciata
in granito a vista e l'interno a tre navate, con le arcate ed i rossi
mattoni delle volte a botte, rappresenta un prezioso esempio di stile
di architettura religiosa in Gallura. Pregevoli le bussole in legno scolpito,
del 1907, il battistero marmoreo del XIX secolo, la Madonna con Bambino,
dipinto manierista del XVII secolo, La Pentecoste, dipinto di
Antonio Caboni (1874), Il Purgatorio, dipinto di Giovanni
Patrone del 1927.
 Prospicente alla parrocchiale vi è la chiesa di Santa Croce,
anch'essa del XVIII secolo, con facciata in granito a vista, sede dell'omonima
Confraternita, che ogni anno cura la realizzazione di un pregevolissimo
presepe. La chiesa di San Pietro è invece una classica
chiesetta risalente al periodo spagnolo del XVII secolo. Meritevole di
una visita anche la piccola chiesa del Purgatorio, del periodo
sabaudo, risalente alla fine del XVIII secolo. Durante il percorso che
porta alla visita di queste chiese si avrà la possibilità
di attraversare i vecchi quartieri del centro storico, ricchi di memoria
e di antico, scolpito nel granito delle case e in sas carreras
e sas atterighìnos, i vicoli stretti che da esse vengono
delineati.
Prospicente alla parrocchiale vi è la chiesa di Santa Croce,
anch'essa del XVIII secolo, con facciata in granito a vista, sede dell'omonima
Confraternita, che ogni anno cura la realizzazione di un pregevolissimo
presepe. La chiesa di San Pietro è invece una classica
chiesetta risalente al periodo spagnolo del XVII secolo. Meritevole di
una visita anche la piccola chiesa del Purgatorio, del periodo
sabaudo, risalente alla fine del XVIII secolo. Durante il percorso che
porta alla visita di queste chiese si avrà la possibilità
di attraversare i vecchi quartieri del centro storico, ricchi di memoria
e di antico, scolpito nel granito delle case e in sas carreras
e sas atterighìnos, i vicoli stretti che da esse vengono
delineati.
Non dimentichiamo le numerose chiese campestri, sempre inserite in incantevoli
scenari naturali ed esempi di una architettura religiosa rurale spesso
semplice, ma ricca di intima devozione. Santa Maria delle Grazie
è una chiesa che faceva certamente parte dell'estinto villaggio
medioevale di Siffilonis. A brevissima distanza da questa sorge
la chiesa di San Pietro, vecchia parrocchiale del villaggio,
purtroppo ora diroccata ed in attesa di un intervento di recupero. A monte
delle prime due troviamo la chiesa di San Leonardo; risalente
all'ottocento, è stata probabilmente edificata sui resti di un'altra
preesistente. La chiesa di San Bartolomeo sorge nella zona di
Carana in un'altura che domina le sponde del Lago del Liscia,
nelle immediate vicinanze dell'olivastro millenario. Di datazione incerta
ma indubbiamente antica, la chiesa è stata ricostruita quasi completamente
nei primi anni '60, dopo che la costruzione dell'invaso del Liscia
aveva sommerso l'antica chiesa di San Nicola. San Michele
di Canaili è anch'essa di origini molto antiche e può
verosimilmente essere considerata la parrocchiale dell'estinto villaggio
medioevale di Canahini.
|
| |
 Le citazioni precedenti sono tratte dall'opuscolo realizzato dalla Associazione
Turistica Pro Loco e dal Comune di Luras
Le citazioni precedenti sono tratte dall'opuscolo realizzato dalla Associazione
Turistica Pro Loco e dal Comune di Luras |
| |
Il
presepe sardo
 Chi
visita il paese durante le festività natalizie può ammirare
il tradizionale presepe di Santa Croce, curato da Pier Paolo Cabras, Priore
della omonima Confraternita, che riproduce ogni anno con l'aiuto dei confratelli,
in un caratteristico angolo, la vita paesana di anni orsono. Una costante
è che la natività avviene sempre in un ambiente che ha come
sfondo il nostro paese, ricostruito con puntigliosa fedeltà mostrando
scorci di Luras. Chi
visita il paese durante le festività natalizie può ammirare
il tradizionale presepe di Santa Croce, curato da Pier Paolo Cabras, Priore
della omonima Confraternita, che riproduce ogni anno con l'aiuto dei confratelli,
in un caratteristico angolo, la vita paesana di anni orsono. Una costante
è che la natività avviene sempre in un ambiente che ha come
sfondo il nostro paese, ricostruito con puntigliosa fedeltà mostrando
scorci di Luras.
La maestrìa, unita alla fantasia, fa sì che il soggetto
muti ogni Natale, pur nel rispetto delle più rigorose tradizioni,
tanto da divenire ormai un appuntamento fisso per il nostro paese.
Il Bambinello, la Vergine e San Giuseppe, nonché i pastori, indossano
i tradizionali costumi locali.

Home
L'autore Le
opere Le
opere La
collezione La
collezione La
tecnica La
tecnica Il
sughero Il
sughero L'edicola L'edicola I
commenti I
commenti |
